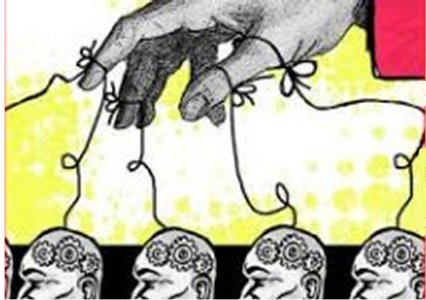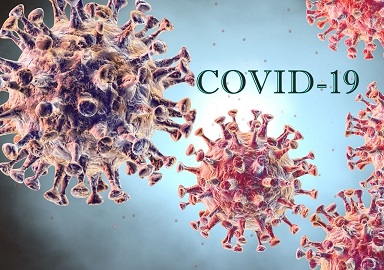“Discutiamo e ragioniamo, ma nella consapevolezza che l’unità del paese uscita dal Risorgimento con i suoi ulteriori sviluppi è l’unica storia che abbiamo, da cui non possiamo prescindere e da cui dobbiamo in ogni caso partire: certo con gli occhi bene aperti ai problemi della difficile unità italiana” Massimo L. Salvadori, storico
lunedì 22 febbraio 2021
lunedì 8 febbraio 2021
il dramma dei confini orientali dal 1943 al 1958
Il 10 febbraio, data della sigla del Trattato di Parigi che sancì nel 1947 il passaggio della sovranità delle terre istriane e giuliane alla Jugoslavia, si celebra il Giorno del Ricordo, istituito con legge n. 92 del 30.03.2004, votata in modo bipartisan dalla stragrande maggioranza del parlamento, “per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”
La spirale di violenza e i conflitti etnici innescati dalla guerra, insieme al clima di confusione che si creò dopo l’annuncio dell’armistizio dell'8 settembre 1943 da parte del maresciallo Badoglio, facilitarono l’occupazione dell’Istria e della Venezia Giulia da parte delle forze partigiane jugoslave che, guidate dal maresciallo Tito, cercavano di liberare tutta la Iugoslavia dalla presenza fascista. Durante la guerra, infatti, in Croazia era nato il regno fascista di Croazia, appoggiato dagli ustascia, avversari etnici dei serbi e del comunismo titino. La resa italiana dell'8 settembre avviò la controffensiva nell'area istriana contro tutti gli italiani responabili di avere appoggiato Mussolini e il fascismo. Vengono colpiti gli esponenti fascisti locali più in vista, i funzionari e gli impiegati dello Stato, gli insegnanti e i ceti produttivi. Una parte delle vittime viene buttata nelle voragini delle zone carsiche (foibe), già utilizzate anche dai nazisti e dai fascisti per rapide e sommarie esecuzioni. Si procede all’uccisone della prima vittima della fila sparando un colpo di arma da fuoco alla nuca, alla faccia o al petto sul bordo del precipizio, in modo che, cadendo nel vuoto, possa trascinare gli altri ancora vivi e legati con fili di ferro tra loro. Dopo l’infoibamento spesso si fanno brillare delle mine in prossimità dell’apertura delle voragini, ottenendo in tal modo l’ostruzione della cavità.Il numero delle vittime resta ancora impreciso ma si pensa raggiunga le cinquemila unità, anche se i corpi recuperati sono meno di un migliaio.
L’esodo
ha riguardato, oltre ai 250.000 italiani, anche 46 mila tra sloveni e croati
che fuggivano dal comunismo. I primi esuli si ricordano nel 1943, gli ultimi
ancora nel 1958. Di questi, circa 70.000
italiani emigrarono all’estero, soprattutto nel Nord e Sud America ed in
Australia. Chi emigrava non poteva portare con sé né denaro né beni mobili (gli
immobili erano comunque considerati parte delle riparazioni di guerra che
l'Italia doveva alla Jugoslavia). Lo storico
d’emigrazione Emilio Franzina
sottolinea che si tratto comunque di un esodo forzoso e che, per avere un’idea
delle sue dimensioni, basta pensare che riguardò l’80-90% della popolazione
italiana residente nell’area. I provvedimenti messi in atto dal governo iugoslavo
per rallentare le partenze sortirono l’effetto opposto perché vennero
interpretati  come controprove della
volontà persecutoria del regime.
come controprove della
volontà persecutoria del regime.
COSA E’ ACCADUTO DOPO?
L'economia
dell'Istria risentì per numerosi anni del contraccolpo causato dall'esodo.
Una
piccola parte della comunità
italiana, soprattutto proletari, scelse, per ragioni ideologiche o per
l'impossibilità "fisica" di affrontare l'esilio (per età, salute,
vincoli famigliari, ...), di non
emigrare e s'integrò nella società jugoslava ottenendo negli anni seguenti il riconoscimento di alcuni diritti, sia
pure più formali che sostanziali;
Alcuni
non si resero conto che l'autorizzazione all'esilio, rilasciata
dalle autorità jugoslave, era soggetta a scadenza, e lasciarono decorrere il
termine, magari per prestare le ultime cure ai campi o alle vigne;
Ad altri Italiani, in generale medici,
tecnici considerati utili dal regime titoista, fu semplicemente negato il
diritto all'opzione e all'esilio; talvolta gli Jugoslavi adottarono l'escamotage di autorizzare la partenza di
tutti i membri di una famiglia tranne un figlio o, preferibilmente, una figlia,
inducendo così anche gli altri a rinunciare.
Oggi vivono nell'Istria slovena
intorno a 3000 membri dichiarati della comunità italiana, mentre il loro numero
in Croazia - fra l'Istria, Fiume e la Dalmazia - si aggira intorno ai 25.000.
Di tutti coloro che esodarono, la maggior parte, dopo aver dimorato per tempi più o meno lunghi in uno dei 109 campi profughi allestiti dal governo italiano, si disperse per l'Italia, mentre si calcola che circa 70.000 emigrarono in altre nazioni. Nel 1948 l’allora capo di stato Luigi Einaudi sostenne l’idea di un forte insediamento in Alto Adige ma il governo si oppose ai concentramenti in poche aree e suggerì la distribuzione dei profughi su tutto il territorio nazionale. I governi italiani per oltre un cinquantennio hanno evitato di affrontare la questione delle foibe e dell'esodo, anche per i forti condizionamenti della guerra fredda.
Soltanto le ricerche degli ultimi decenni hanno permesso di fare luce sul dramma dei confini orientali, sulle foibe e sull'esodo. Oggi una legge ci aiuta ad averne perpetua memoria.
SEZIONE SPECIALE DI RAI CULTURA
DEDICATA ALLA TRAGEDIA DELLE FOIBE E DELL'ESODO ISTRIANO
DA FOCUS: I MASSACRI DELLE FOIBE
mercoledì 3 febbraio 2021
lunedì 1 febbraio 2021
quando si può parlare di totalitarismo?
- culto unico di un capo, il rapporto privilegiato tra il leader e la massa, tra il capo e la folla
- coinvolgimento emotivo e irrazionale delle masse attraverso una "fede laica comune"
- destinato a masse non politicizzate, indifferenti, apatiche, scartate dagli altri partiti
- metodi di propaganda
- costruzione di un apparato simbolico, quasi liturgico, per una nuova religione
- mobilitazione dei cittadini attraverso organizzazioni statali per frenare il dissenso
domenica 24 gennaio 2021
GIORNO DELLA MEMORIA 2021
SEGNALIAMO LINK, FILM, SITI CHE POSSONO ESSERE CONSULTATI
PER ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE CLASSI
LA POLITICA RAZZIALE IN GERMANIA E IN ITALIA
giovedì 17 dicembre 2020
DALLA PESTE NERA AL COVID19. PANDEMIE NELLA STORIA
video Zanichelli, durata 1,35'
COSA ACCADDE? PERCHE'? CON QUALI CONSEGUENZE?
proposta di Samuele Finocchiaro, 3 I
dal 430 a.C. al Covid19 del 2019
LEONARDO PREVITERA PRESENTA
LA CRISI DEL TRECENTO
CON ANALOGIE E DIFFERENZE COL COVID 19
LE SLIDES DI LEONARDO PREVITERA, 3 E
di Gianluca Lo Re, 3 E
giovedì 10 dicembre 2020
LA MAGNA CHARTA LIBERTATUM
La prima traccia storica di affermazione scritta dei diritti umani, seppur embrionali e limitata agli “uomini liberi”, si trova nella Magna Charta Libertatum (dal latino medievale), comunemente chiamata Magna Carta (1761), accettata il 15 giugno 1215 dal re Giovanni d'Inghilterra (soprannominato anche "Giovanni Senza Terra", perché aveva perso i suoi feudi) a Runnymede, nei pressi di Windsor. Redatta ( ma non nei contenuti, solo nella forma) dall'Arcivescovo di Canterbury per raggiungere la pace tra l'impopolare re e un gruppo di baroni ribelli, la Carta andò oltre all'affrontare le semplici richieste baronali, ma costituì una proposta più ampia di riforma politica.
Essa prometteva la tutela dei diritti della Chiesa, la protezione dalla detenzione illegale, la disponibilità di una rapida giustizia e, soprattutto, introduceva delle limitazioni in materia di tassazione e altri pagamenti feudali alla corona, con alcune forme di tassazione feudale che richiesero il consenso baronale. La Carta vantava la promozione di diritti libertari per gli uomini, in particolare per i baroni. Tuttavia, anche i diritti dei servi vennero presi in considerazione
negli articoli 16, 20 e 28. La Magna Charta Libertatum sancisce il principio dell’habeas corpus, il quale verrà sviluppato nell’Habeas Corpus Act (L'Habeas corpus fu sancito nel 1679 e 1816. Esso stabilisce il principio della garanzia della libertà del cittadino, che non può essere arrestato o subire limitazioni alla sua libertà personale, se non è data dall'autorità la prova del reato commesso) e nel Bill of Rights (1689) che ha dato vita alla monarchia costituzionale inglese.
A seguito dell'approvazione monarchica della Magna Charta libertatum si avvia la costituzione del Parlamento inglese:
nel 1242 nasce la Camera dei Lords
nel 1339 si aggiunge la Camera dei Comuni
dal 1348 il ruolo del Parlamento bicamerale inglese viene ribadito nel giuramento del re
OGGI
il Parlamento inglese conserva la sua struttura bicamerale
UNA SCHEDA DI ANALISI DELLA CARTA
LA MAGNA CHARTA LIBERTATUM CON I SUOI 63 ARTICOLI
Le origini del costituzionalismo moderno
Con la Magna Charta i rapporti feudali, che fino ad allora avevano avuto carattere personale e privato, furono codificati per la prima volta in diritto pubblico. Questo diritto, che fu detto comune (common law) perché comune al re e ai baroni, costituiva il terzo sistema giuridico dell’Europa medievale, accanto al diritto romano e al diritto canonico (cioè ecclesiastico).
L’importanza storica della Magna Charta consiste nel fatto che essa riconosceva per la prima volta l’inviolabilità dei diritti individuali rispetto a ogni arbitrio di potere; tuttavia essa, in origine, difendeva soltanto i diritti e i privilegi di nobiltà e alto clero, ignorando contadini, artigiani e tutti gli altri appartenenti ai ceti inferiori.
Nei secoli successivi questo documento, nato per restaurare la pratica e il diritto feudale, divenne la base per l’affermazione di diritti e istituzioni propri del costituzionalismo moderno (la teoria che difende le libertà individuali). Così, per esempio, dal Consiglio comune del regno derivò il Parlamento inglese, che nel Trecento si divise in due Camere, la Camera Alta o Camera dei lord (in cui sedevano i nobili e il clero) e la Camera Bassa o Camera dei Comuni (dove si radunavano i rappresentanti degli ordini sociali meno potenti). Inoltre, il diritto a processi imparziali e secondo la legge venne allargato a tutti i cittadini e il divieto di arresti arbitrari fu garantito dalle successive norme sull’habeas corpus, le quali stabilivano che la persona arrestata (il «corpo») dovesse essere condotta in tempi brevi di fronte a un giudice. La protezione degli uomini liberi contro i soprusi dei feudatari rappresentò la prima affermazione dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.